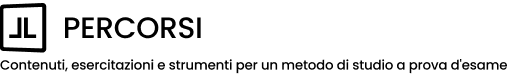Nell’ambito di un procedimento a carico dell’indagato, accusato di riciclaggio, abusivismo finanziario e indebito utilizzo di carte di credito, il GIP disponeva il sequestro preventivo della somma di €206.442,32, oltre che delle carte di credito, dei dispositivi elettronici e dei telefonini, già oggetto di sequestro probatorio da parte del PM.
Respinto il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo dal Giudice del riesame, l’indagato ricorre per cassazione lamentando, in particolare, l’omessa motivazione da parte del Giudice sui motivi attinenti all’elemento soggettivo del reato.
Ebbene, la Cassazione rileva quanto ricostruito dal Tribunale in ordine alla vicenda e, con riferimento ai proventi della truffa, osserva che l’indagato non si è limitato ad occuparsi di acquisto e cessione di criptovalute, ma si è inserito attivamente nell’apertura di conti correnti sui quali confluivano i proventi delle truffe, che venivano poi utilizzati per le relative transazioni. Per tale motivo, secondo la Corte, la motivazione fornita dal Tribunale, secondo cui «le citate circostanze in sede di indagini appaiono difficilmente compatibili con un atteggiamento psicologico diverso dal dolo in relazione al reato di cui al capo A)» sembra esenti da censure.
In ordine poi alla censura con cui il difensore sostiene che le valute virtuali non sono prodotti di investimento, ma mezzi di pagamento, rimanendo così sottratte alla normativa in materia di strumenti finanziari, la Suprema Corte afferma che essa non si confronta la motivazione contenuta nell’ordinanza impugnata, laddove si sottolinea che «la vendita di bitcoin veniva reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, tanto che sul sito ove veniva pubblicizzata si davano informazioni idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all’iniziativa, affermando che “chi ha scommesso in bitcoin in due anni ha guadagnato più del 97%"». Dunque, deve ritenersi che tale attività si è sostanziata in un’attività «soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti t.u.f., la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all’art. 166, comma 1, lett. c) t.u.f.».
Infine, per quanto concerne l’indebito utilizzo della carta di credito, la Cassazione precisa che tale uso da parte di un terzo, autorizzato dal titolare, integra il reato di cui all’art. 12 d.l. n. 143/1991, come convertito nella l. n. 197/1991, ora art. 493-ter c.p., «in quanto la legittimazione all’impiego del documento è contrattualmente conferita dall’istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all’eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, stanti la necessità di firma all’atto dell’uso, di una dichiarazione di riconoscimento del debito e la conseguente illiceità di un’autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare, ad eccezione dei casi in cui il soggetto legittimato si serva del terzo come "longa manus" o mero strumento esecutivo di un’operazione non comportante la sottoscrizione di alcun atto».
Ciò posto, conclude la Corte, il fatto che nella fattispecie si trattasse di una carta di debito anziché di credito è del tutto irrilevante, considerato che «il bancomat è un documento analogo alla carta di credito che abilita al prelievo di denaro contante e quindi rientra nell’art. 493-ter c.p.».
Fonte: Diritto e Giustizia