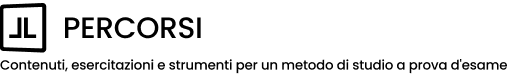Ai fini della sussistenza del delitto di atti persecutori non importa quale sia il mezzo attraverso il quale si manifestano le condotte incriminate, quanto piuttosto le modalità di queste ultime, dalle quali deve emergere l'effetto vessatorio sulla persona offesa.
La persecuzione mediatica. In questo caso il “media” prescelto è l'arcinoto social network Facebook, che conferma ancora una volta la sua natura multiuso: con Facebook sbocciano improvvisi amori, si ritrovano vecchie amicizie e – purtroppo – si commettono anche gravi reati. Nel caso che ci occupa le malcapitate persone offese sono due amministratori di un piccolo Comune siciliano. Entrambi finiscono nel mirino di un tale che evidentemente non è un loro simpatizzante. Anzi, stando alle poche righe della sentenza dedicate al fatto storico che ne ha giustificato la pronuncia, sembrerebbe che l'azione dell'imputato sia andata ben oltre la – magari veemente – critica politica. Condannato in primo e secondo grado per diffamazione e atti persecutori, l'autore di quelle condotte veicolate a mezzo Facebook tenta il tutto per tutto affidandosi al ricorso per cassazione. Che non avrà l'effetto sperato.
Lo stalking può commettersi mediante Facebook? Una delle doglianze spiegate avverso la sentenza d'appello concerne la configurabilità del delitto di atti persecutori per mezzo di messaggi et similia veicolati a mezzo internet. Il motivo di gravame, secondo il ricorrente, trova il suo fondamento in un orientamento di legittimità del 2016 che escluderebbe la commissibilità di questo reato per mezzo di strumenti telematici. Gli Ermellini colgono l'occasione per fare chiarezza: vero è che nel 2016 si era formato un indirizzo interpretativo secondo il quale la pubblicazione anche reiterata di articoli giornalistici a contenuto diffamatorio non integrava gli estremi del delitto di stalking. Alla stessa maniera nel 2020 si affermava che non valeva ad integrare il reato nemmeno la pubblicazione di post irridenti su una pagina Facebook accessibile a chiunque. La ratio di quest'ultimo indirizzo risiede nella “assenza del requisito della inevitabile invasività della sfera privata della vittima”. Nessuno di questi due filoni ermeneutici ha inteso far sorgere il principio di diritto che il ricorrente aveva ritenuto di ravvisare in quelle “massime”: e meno male, aggiungiamo noi, altrimenti dovrebbe pervenirsi alla inaccettabile conclusione che lo strumento informatico – in contraddizione con quanto prevede la lettera della legge, che invece considera l'uso del mezzo telematico come un'aggravante – non sarebbe nemmeno astrattamente idoneo a porre in essere una condotta persecutoria.
La precisazione degli Ermellini: tutto dipende dalle condotte “incriminate”. La Cassazione, lungi dall'avallare la tesi interpretativa che veniva prospettata nel motivo di ricorso, ha subito precisato che non vi è mai stata un'aprioristica esclusione di Internet (e di Facebook) dal novero degli strumenti con i quali può commettersi il reato di stalking. Anzi, nelle aule di giustizia si è a più riprese affermato l'esatto contrario, così come dimostra la nutrita casistica citata nel corpo della motivazione della sentenza che commentiamo. Si è precisato sin dal 2010 che l'invio alla persona offesa di “sms” ed email, o “post” sui social network valgono ad integrare il reato in questione; così come identica valenza possono assumere l'invio di foto o altro genere di messaggi dal contenuto denigratorio. Ecco che, in definitiva, non rileva tanto il mezzo attraverso il quale si pone in essere la condotta illecita, quanto piuttosto a fare da guida deve essere la concreta modalità con la quale la prima si è manifestata. L'effetto – che va rigorosamente dimostrato – è quello dell'effetto vessatorio sulla persona offesa, la quale deve quindi essere rimasta vittima di una vera e propria azione persecutoria posta in essere nei propri confronti. Non è dirimente nemmeno il modo con il quale i messaggi – in gergo, appunto, “post” - siano divulgati: se non pongono dubbi quelli inoltrati al “profilo” della persona offesa (che viene attinta così da vicino nella propria individualità e, per l'effetto, percepisce direttamente il messaggio minaccioso), non devono nemmeno ritenersi privi di rilievo i “post” pubblicati sul profilo dell'autore del reato: in questo caso vale sempre il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo il quale ai fini dell'efficacia delle minacce non è detto che queste debbano necessariamente essere pronunciate in presenza della vittima. Lo stesso principio può ritenersi, secondo i Supremi Giudici, applicabile anche al caso dello stalking che, quindi, dimostra di essere rispondente ad uno schema ibrido: nonostante sia un reato abituale a forma vincolata, quest'ultima in realtà è tale soltanto nel rispetto della sequenza fenomenica “molestia-minaccia - ansia-timore”, ma rimane pur sempre commissibile in tutti i modi nei quali una condotta petulante o minacciosa può concretizzarsi.
Fonte: Diritto e Giustizia